Quando, nel 2012, lasciai l’azienda di produzione che avevo fondato con mio fratello, per tornare ad occuparmi di comunicazione, lo feci con consapevolezza e convinzione, ma con l’umiltà necessaria per comprendere che i sei anni che erano trascorsi rappresentavano un tempo infinito in un’epoca fortemente condizionata dal cambiamento. Sapevo di dover studiare, ma decisi di farlo come chiunque si approcci per la prima volta ad una materia, nonostante quella fosse stata, per anni, la mia occupazione principale. Non ho fatto corsi, non ho partecipato ad eventi né a convegni. La prima cosa che mi sono chiesto, guardandomi intorno, era il motivo per il quale, in quella che tutti decantano come l’era digitale, con un accesso spesso gratuito alla maggior parte delle fonti, ci fosse una così alta incidenza ed esigenza di fisicità. Col tempo, poi, ho capito che è un’esigenza indotta, ed ho anche compreso il perché. Ma non è questo il nocciolo della questione.
Il punto, piuttosto, è che trovavo semplice selezionare fonti italiane e straniere, con approfondimenti che mi davano tante indicazioni utili e che mi hanno portato a comprendere come le leve della comunicazione e dell’informazione fossero sempre più simili, quasi identiche, fino a renderle praticamente sovrapponibili. Quelle fonti, ovviamente, erano alla portata di chiunque sapesse cosa cercare. O, quantomeno, di chi avesse ben chiaro, dentro di sé, dove volesse arrivare. Ciò che mi sembrava evidente, in questo senso, era che mi iscrivevo ad una regata nella quale, gli altri competitor, avevano iniziato sei anni prima di me. Avevo due possibilità, quindi: mettermi in scia o, come si dice nel gergo della vela, andare a cercarmi il vento.
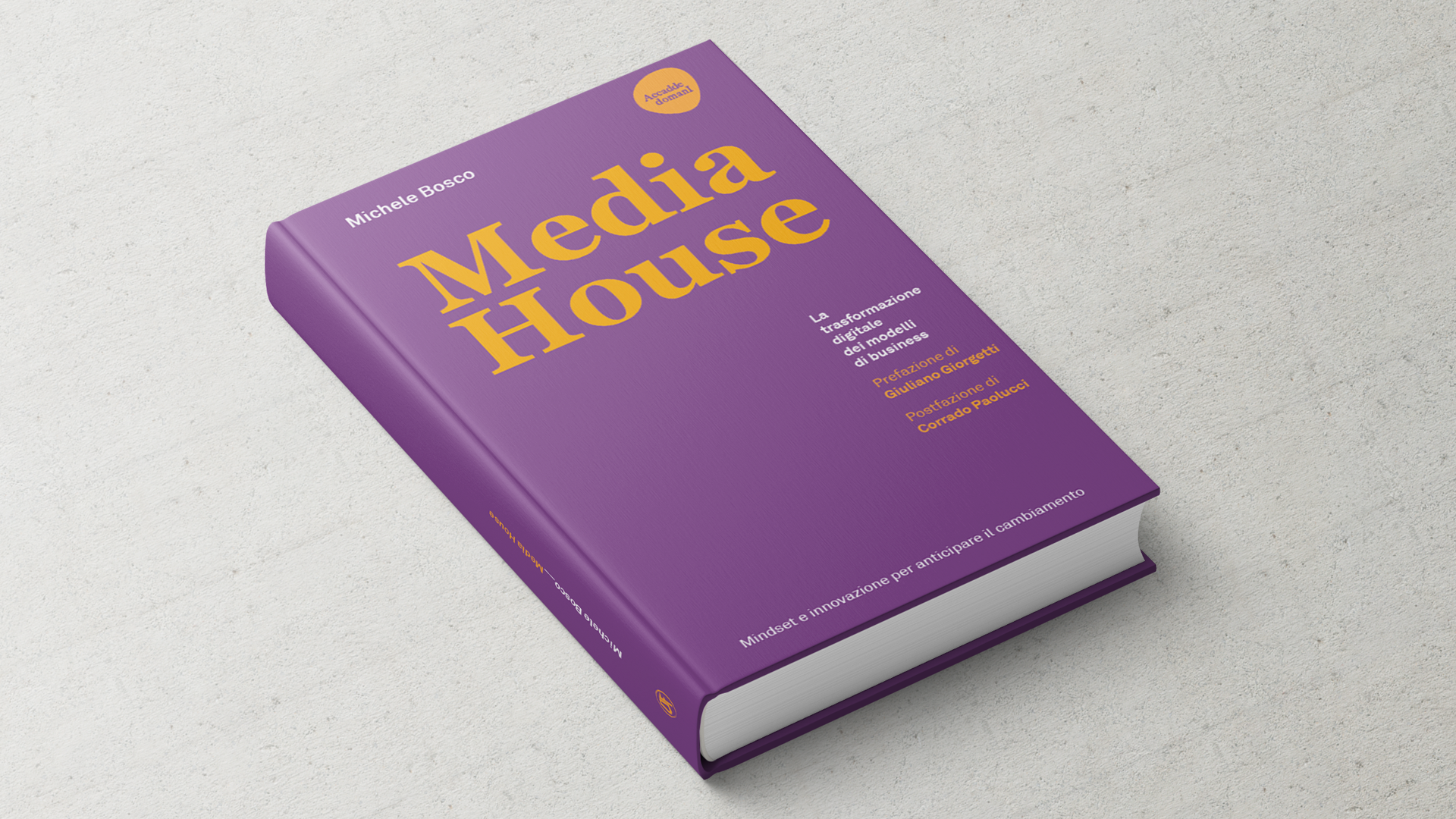
Così, scrutando un orizzonte nel quale molti avevano già puntato sui blog, più o meno verticali che fossero, all’interno o all’esterno dei loro siti vetrina, io decisi di fondare Virtual14, puntando dritto sul brand journalism, con un magazine che sostituiva totalmente la struttura classica, più diffusa e più istituzionale. Ricordo che tanti, quasi tutti, mi dicevano che non si capiva bene di cosa ci occupassimo, ma non era vero. La realtà è che il mercato non era ancora pronto a quella forma di pubblicità. Ero certo, infatti, che con un po’ di tempo a disposizione, sarebbe risultato evidente attraverso i contenuti che avremmo pubblicato e che avrebbero alimentato quel magazine (e da lì tutti gli altri canali che andavamo a presidiare), consentendoci, se avessimo lavorato bene, di creare relazioni coi protagonisti dell’ecosistema in cui andavamo ad operare, catturando l’attenzione dei manager delle aziende per cui volevamo lavorare e dei target che volevamo informare e intrattenere. Iniziando, contestualmente, ad essere percepiti nel modo corretto, attraverso competenze che non venivano descritte o decantate, quanto concretamente manifestate, lasciando il nostro brand dietro le quinte e facendo in modo che emergesse prepotentemente nel momento in cui, le nostre audience, avrebbero avuto bisogno dei nostri servizi.
Ovvero, appunto, proprio dei contenuti.
Quale pubblicità migliore, mi chiedevo, rispetto alla produzione e alla diffusione di contenuti di qualità, di contenuti utili, di contenuti facilmente fruibili ed esteticamente godibili, prodotti nei formati corretti e diffusi attraverso i canali giusti, considerando che era ciò per cui volevamo posizionarci? Così andai avanti in un percorso che si sarebbe rivelato stimolante, sfidante e ricchissimo di soddisfazioni. Il magazine, inoltre, diventava anche uno strumento gestionale, che ci aiutava ad accentrare tutta la produzione di contenuti da declinare sulle altre piattaforme. I temi su cui informare, le competenze da manifestare, i target con cui dialogare e i pubblici da intercettare, ne diventavano le categorie. Così come, un’altra categoria, doveva essere il racconto delle attività di quella nuova piccola azienda, che aveva tanta strada da fare, ma senza strafare. Per evitare di essere autoreferenziali, stabilii che il giusto rapporto fosse 80/20, in cui, la percentuale più alta di quanto dovevamo produrre, era da focalizzare sugli altri, da rendere protagonisti di una narrazione ad alto impatto informativo. Così facendo, saremmo riusciti a portare l’attenzione su di noi stessi nel modo giusto.
Release 2.0 di Esther Dyson
I collaboratori, a propria volta, dovevano essere gli autori di quel brand magazine, scrivendo e producendo contenuti in base alle proprie competenze, mantenendo alto il livello della qualità e contribuendo a variare il piano editoriale che, così facendo, sarebbe stato allo stesso tempo verticale (per temi) e orizzontale (per ecosistemi e protagonisti). Attuare quel piano, avrebbe significato creare opportunità commerciali indirette, facendo per gli altri quello che facevamo per noi stessi, ma anche ritrovarsi tra le mani un media che, di per sé, poteva diventare appetibile per rappresentare il mezzo, nell’accezione più diretta del termine, per chi fosse interessato a relazionarsi con i differenti target ai quali avremmo parlato quotidianamente. Mi sembrava un incastro perfetto, nelle idee, nelle modalità e nelle intenzioni. I risultati, guardandomi indietro, mi hanno dato ragione, ma, quello che mi ha reso più orgoglioso, è ciò che osservo oggi, con una visione che si concretizza giorno dopo giorno, proprio in quella nuova direzione.
Ma di cosa c’è bisogno, per realizzarla?
Quali sono le strutture, gli strumenti, le competenze, le funzioni e l’organizzazione necessaria per attuare questa strategia, a prescindere dal settore di riferimento e dal contesto?
Volendo evitare i soliti manuali, e tentando di descrivere sempre e solo situazioni reali, dalle quali poi, chiunque può trarre le proprie indicazioni e le sue conclusioni, ho deciso di scrivere un libro (dal 5 novembre in libreria e online) dedicato alla Media House, la struttura ibrida – con competenze trasversali – di cui si stanno dotando le aziende più evolute per farsi broadcaster, media ed editori, per intrattenere, informare, formare ed educare i propri target, con l’obiettivo di instaurare con essi delle relazioni profonde e individuali, conquistandone i dati, la fiducia e la fedeltà per generare occasioni commerciali.
Partendo dalle evoluzioni della comunicazione e dalla crisi dell’informazione – in un testo che ha i tratti del reportage, segnato da un dettagliato lavoro di ricerca che nasce da articoli scritti durante la mia carriera, e che prosegue attraverso fonti, citazioni e l’analisi di specifici contenuti e casi studio a supporto delle idee che ho tentato di proporre –, provo a spiegare le opportunità del brand journalism come strategia di marketing e il nuovo ruolo delle aziende nello scenario informativo, per colmare i vuoti di fiducia generati da media e politica. La trasformazione digitale, infatti, ha cambiato le abitudini delle persone e abilitato nuovi comportamenti, evolvendo gli stessi processi di comunicazione e informazione, che ormai convivono con opinione e narrazione. I lettori, gli utenti e i clienti, a propria volta, sempre più egocentrici e protagonisti, non si limitano più a leggere, osservare, scegliere ed acquistare, vogliono partecipare. I modelli di business, di conseguenza, vanno ripensati, con brand e newsbrand chiamati a pianificare nuove esperienze per coinvolgere le persone e catturarne l’attenzione.
Da molti anni – come accennato –, sul mio magazine ma anche su altre riviste, blog e testate, scrivo di giornalismo aziendale e non solo. Il mio percorso professionale, che nasce nello sport marketing ma che si sviluppa attraverso esperienze dirette e grazie al contatto e alla contaminazione con numerosi professionisti di media, agenzie e aziende di differenti settori e dimensioni, mi ha portato a conoscere da vicino e ad elaborare i molteplici aspetti di cui si compone, oggi, un nuovo modo di pensare che è alla base del libro – che annovera una sitografia/bibliografia di più di 150 fonti – e di tutti i casi studio che ho analizzato, tra i quali Eni Media House rappresenta di sicuro l’esempio più tangibile e del quale, per questo, ho voluto approfondire strutture, organizzazione, approccio, metodo, valori, identità e capacità di relazione con le audience di riferimento, fino alle modalità di produzione e distribuzione dei contenuti e alla gestione delle piattaforme e dei dati, per rimarcare i processi ottimali e le risorse essenziali per puntare all’omnicanalità. Un aspetto, quest’ultimo, che mi ha aiutato anche a dimostrare l’assunto secondo cui, questa traiettoria evolutiva, porta il mondo della comunicazione aziendale a sovrapporsi a quello degli organi d’informazione in molti punti, per la stessa esigenza di attenzione da parte della gente.
Con ‘Media House’ (con la prefazione di Giuliano Giorgetti, la postfazione di Corrado Paolucci e il prezioso contributo di professionisti tra i quali Goffredo D’Onofrio, Guido Vaciago, Federico Ferrazza, Giorgio Soffiato, Emanuela Perinetti, Luigi Di Maso e Alessandro Giagnoli), inoltre, ho esaminato anche varie eccellenze (tra cui le strategie di importanti club sportivi, aziende e media, nel tentativo di dimostrare quanto i percorsi della loro trasformazione digitale porti i differenti modelli verso lo stesso punto d’arrivo, a prescindere da quello di partenza) legate al brand entertainment e alla brand religion, menzionando giornalisti, comunicatori e importanti studi accademici – tra cui quelli del Prof. Piero Dominici, che già dagli anni ’90 indaga il tema della complessità –, per evidenziare i percorsi formativi ormai indispensabili – superando la dicotomia tra studi umanistici e scientifici, e, anzi, imparando ad abitarne i confini – per chi vuole occuparsi, nella società interconnessa, iperconnessa e ipertecnologica, di informare e di comunicare il sapere e il saper fare.
Un viaggio che parte da lontano, quindi, il mio, che con questo libro mi ha permesso di esplorare vecchi e nuovi territori, sempre con lo stesso obiettivo: dimostrare che «ogni azienda è un media».
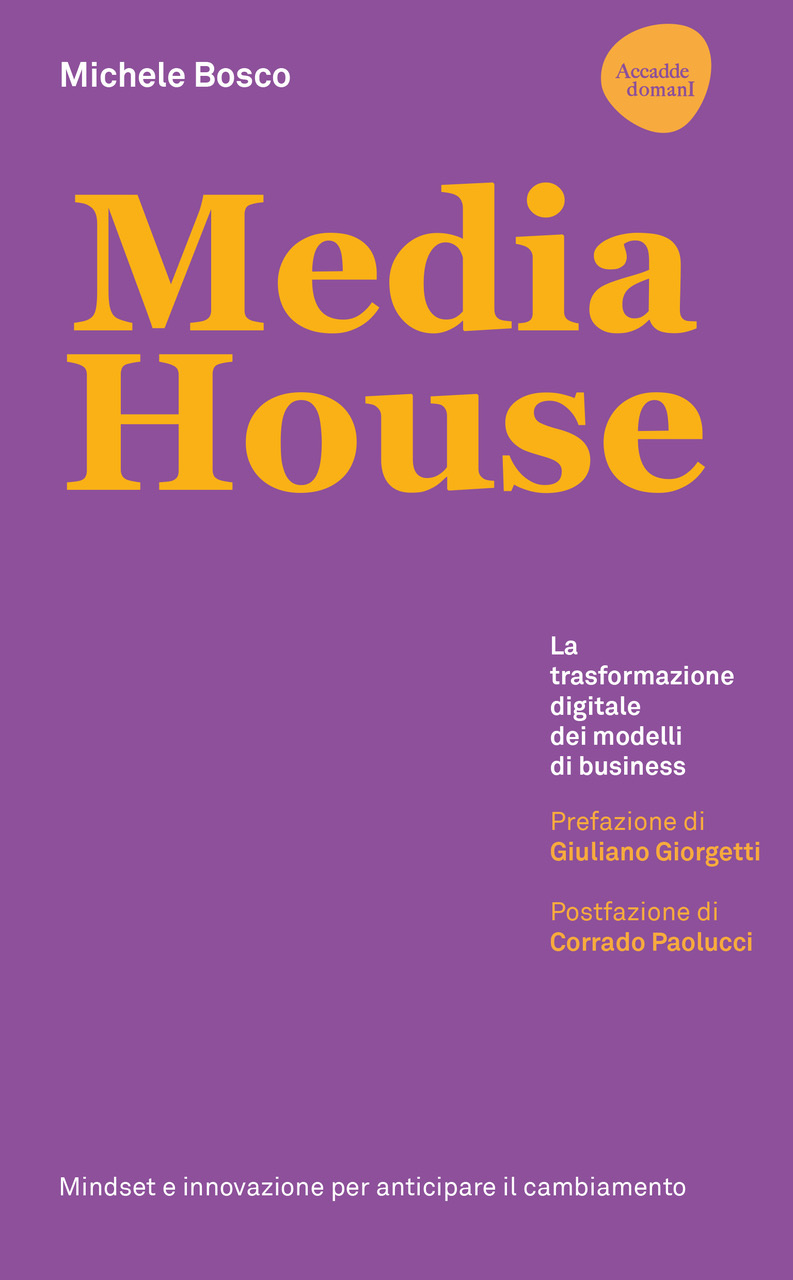
L'autore
Specializzato in sport marketing, con esperienze in società sportive, aziende e agenzie, Michele Bosco si occupa di comunicazione digitale ed è tra i primi in Italia a scrivere di brand journalism, anticipando una visione sempre più attuale negli scenari di business.

