Per cercare qualcosa di filosofico nella narrativa tolkieniana bisogna cominciare col cambiare idea su cosa sia “filosofia”.
Se si pensa ai dialoghi platonici o ai trattati di etica o di metafisica, in ogni caso a ciò che rientra nel canone del pensiero filosofico occidentale, allora forse l’unico che può soddisfare questi requisiti potrebbe essere Dante Alighieri, nell’intero panorama letterario occidentale. Neppure l’immenso Leopardi rispecchia i canoni classici del “pensare filosoficamente”, pur essendo il maggior filosofo italiano dell’Ottocento.

J.R.R. Tolkien
C’è tuttavia un modo alternativo di “pensare filosoficamente” che a volte non è neppure consapevole, come certamente è il caso di Tolkien. Questo modo non è teoretico (che è un modo elegante per dire “accademico”, cioè da addetti ai lavori), ma pratico, col che indichiamo quella filosofia che chiede di essere vissuta. Vivere filosoficamente non vuol dire darsi all’eremitaggio, ma impegnarsi su alcune questioni fondamentali che concernono il senso: l’amore e la morte, il bene e il male, giustizia e pietà, potere e cura come essere-per-l’altro. Che sono poi i grandi temi del ciclo tolkieniano.
Ciascuno di noi può “impegnarsi” su queste cose ri-pensandole, non “dandole per scontate” ma chiedendosi che cosa veramente vogliono dire, per essere pronto nei momenti cosiddetti Cruciali; uno scrittore si impegna scrivendo. Tolkien ha il grande merito di aver riportato l’attenzione del Novecento su questioni che parevano ormai fuori dalla nostra portata. La letteratura del Novecento è infatti la “letteratura del disincanto”, degli eroi negativi che stanno alla finestra perché “nulla vale il loro sforzo” (attenzione: l’eroe che fallisce è quello romantico; il fallimento infatti implica di essersi prima impegnati, ma il Novecento rifiuta ogni impegno che non sia meramente ideologico).
Il protagonista del SdA è invece un eroe che si impegna, pur fallendo; ma non è un eroe romantico poiché non una sola volta pensa di essere senza macchia e senza paura. Egli crede di essere dalla parte della verità, come lo crediamo tutti, ma sa di non esserne all’altezza. È dunque un personaggio novecentesco perché è “piccolo” – in tutti i sensi – ma è un antieroe in un senso molto diverso da quello a cui di solito si pensa.
Parlare di UN protagonista è molto riduttivo: diciamo che sono almeno due, col loro seguito di adiuvanti (come si dice in semiologia). L’antagonista, invece, è uno, ma ha la proprietà di non comparire mai e di non dire neppure una parola. È il Male che, agostinianamente parlando, si manifesta come “assenza di bene”. È il Nero, il vuoto assoluto, il Buio della mente. Per “metterla duramente”, diciamo che i veri protagonisti del SdA sono il Bene e il Male (o meglio: protagonista VS antagonista). È qui che la critica letteraria si è scatenata in beffe e sarcasmi: “ma andiamo, il bene e il male non esistono! Esiste solo la psicologia, che in Tolkien latita completamente”. Vediamo.
Bene e Male, nel SdA, compaiono in due modi molto distinti. In senso lato, essi appaiono per quello che sono sempre stati nell’immaginario collettivo della nostra civiltà: la luce contro l’oscurità. Tolkien non fa crociate, non è un americano, dice semplicemente: così abbiamo diviso il mondo, così ci sentiamo nel mondo: desiderosi di luce e spaventati dal buio. Ma, al di là di questo, come appaiono veramente Bene e Male, nel romanzo? Semplicemente non appaiono. È vero che se ne parla molto e che all’orizzonte incombe una minacciosa oscurità dall’inizio alla fine del romanzo; ma noi che cosa facciamo quotidianamente, se non evocare pericoli e temere qualcosa? In realtà, Bene e Male autentici sono entità che riguardano la vita di ognuno, ma, dice ancora Tolkien, nessuno è mai totalmente buono o malvagio.
Frodo non è totalmente buono perché alla fine cade e si trasforma in nemico.
Gollum non è totalmente cattivo perché è ancora capace di concepire affetto e lealtà.
Ognuno, dice Tolkien, può scegliere di essere buono o malvagio; e se alla fine cade, come succede a Frodo, quello che conta non è la singola colpa, ma la scelta di una vita. Frodo si salva perché ha vissuto nell’amicizia e nella pietà, cioè dalla parte del bene, non perché è un eroe.
L’edizione in lingua inglese del Signore degli anelli con le illustrazioni originali di Alan Lee, poi scenografo nella celebre riduzione cinematografica di Peter Jackson
Il SdA è una perfetta ricostruzione del mondo medievale, a partire dai testi e dall’immaginario che quel mondo ha prodotto. Manca però una cosa molto medievale: mancano religione e chiesa. Non c’è un monaco, non c’è alcun accenno alla creazione o alla redenzione, non ci sono chiese e monasteri. È un medioevo totalmente laico. Ma non è una laicità “a misura di Novecento”. Facciamo alcuni esempi.
Ci sono alcune cose di cui il cristianesimo si è impadronito, facendole surrettiziamente proprie:
1) la pietà. Il SdA si fonda, psicologicamente parlando, su due atti di pietà: il primo è un antefatto, e compare nello Hobbit, quando Bilbo si astiene dall’uccidere Gollum (potendolo fare senza alcun rischio) perché ha pietà della sua umana miseria. Ciò avrà due conseguenze fatali: Gollum vivrà, e risolverà a modo suo il conflitto tra Bene e Male, e l’Anello non nuocerà a Bilbo poiché egli ha il cuore nobile e non corrotto. Il secondo è ancora più profondo: Frodo ha pietà di Gollum e lo accetta come compagno di viaggio, pur potendosene sbarazzare e perfino uccidere. Il perché di questo sentimento lo vedremo più avanti. Ma cos’è la Pietà? È accettazione dell’altro? È solidarietà? È umiltà? Sono virtù necessariamente cristiane? E perché mai?! Sono virtù filosofiche? Forse…
🍒🍒DISORIENTATI E IN FUGA NEL METAVERSO
2) la Kenosis. In greco: “svuotamento”, “spogliazione” (in teologia, l’incarnazione di Dio). Nel SdA tutti i potenti rinunciano alla loro potenza, e con un atto molto semplice: rinunciano all’Anello, cioè al potere supremo, per donarsi al più umile di tutti, un semplice Hobbit (come a dire, al figlio di un falegname). Il trionfo del Bene è legato alla rinuncia ad ogni forma di supremazia. E alla fine di tutto, il re di Gondor (la superpotenza) si inginocchierà di fronte a Frodo e Gandalf gli legherà i calzari.
Sia la filosofia che la psicologia possono spiegare tutto questo senza ricorrere alla teologia. Non dico alla teologia che tratta del divino, ma di quella parte di essa che prescrive ciò che è umano. Si possono fare discorsi serissimi sull’uomo senza abusare del “potere della Parola”, senza cioè ammantarsi di dogmi e di verità imperscrutabili.
La pietà. C’è un unico personaggio, in tutto il romanzo, che merita la nostra pietà, ed è Gollum (il problema della violenza senza se e senza ma che è riservata agli orchi è una questione ovviamente seria, poiché ad essi è riservato solo l’abominio; così come agli “spettri dell’Anello”, di cui è auspicabile la fine assoluta… ed è questo l’aspetto più “teologico” del romanzo). Gollum-Smeagol è un “essere umano” che ha ceduto alla tentazione. Il suo cuore un tempo sano si è corrotto irrimediabilmente, ma non tutto è perduto. Se vogliamo è schizofrenico (parla infatti da solo, al suo alter ego, ed oscilla tra impulsi di morte e impulsi d’amore). La sua malvagità è solo debolezza. La vera natura di Gollum emerge quando egli è al fianco di Frodo, il Portatore dell’Anello come fu Gollum molto tempo prima. Psicologicamente parlando – secondo la psicologia junghiana – Gollum è l’Ombra di Frodo (c’è un punto nel romanzo in cui Sam, guardando Frodo che fronteggia Gollum, non riesce più a distinguere l’uno dall’altro: c’è tra loro molta più somiglianza di quanto sembri).
«Con Ombra intendo la parte negativa della personalità, la somma cioè delle qualità svantaggiose che sono tenute possibilmente nascoste e anche la somma delle funzioni difettosamente sviluppate e dei contenuti dell’inconscio personale.» [Jung, Psicologia dell’inconscio]. È scritto molto chiaramente da Tolkien che Frodo sa che anche lui può diventare come Gollum, o potrebbe diventarlo, se solo cedesse alla tentazione di usare l’Anello. Ma la fortuna di Frodo è che egli lo sa. Ne è assolutamente consapevole. Egli sa quanto soffrirebbe se diventasse come Gollum. Frodo accoglie la propria Ombra: questa è la pietà intesa psicologicamente.
La Kenosis. Quello della “spogliazione” è un rito tipicamente medievale [vedi: Guglielmo il maresciallo, di G. Duby]. È un tema anche filosofico, se prendiamo a riferimento il principio neoplatonico dell’epistrophé. Junghianamente, potremmo dire che è un archetipo: è cioè una figura universale dell’immaginario umano, non esclusiva quindi del cristianesimo (tant’è vero che san Paolo la usa per spiegare teologicamente l’incarnazione).
La rinuncia al potere è un tema di poco successo nella letteratura di ogni epoca. Per lo più si lotta contro il potere, allo scopo di portate il Bene lì dove vige il Male. Ma il principio della Kenosis implica che non è questa la strada giusta. Per Tolkien, l’Anello del potere va distrutto. È vero che anche in Wagner l’Anello del Nibelungo alla fine sarà distrutto dalla walchiria, ma, appunto, alla fine. Nel SdA la scelta di rinunciare al Potere è la prima opzione e rimane l’unica fino alla fine. Simbolicamente e narrativamente è ovvio che l’Anello vada fisicamente annientato, ma la Kenosis, la rinuncia al potere, è già avvenuta.
Quali sono i personaggi che rifiutano l’Anello?
Gandalf, all’inizio, quando Frodo gli chiede di “togliergli quel peso che lui non può portare” (quasi una citazione della paura di Cristo sul Monte degli ulivi).
Galadriel, la regina degli Elfi, di nuovo pregata da Frodo. Come Gandalf, anche lei parla di tentazione. Come non pensare alla pagina del Vangelo sulle tentazioni di Gesù nel deserto.
Aragorn, nella svolta prima della separazione da Frodo. Lui lo fa per pietà e fedeltà.
Faramir, il figlio del Sovrintendente di Gondor. Come Aragorn, egli è spinto dalla pietà e dalla nobiltà del suo sentire.
Sono tutti personaggi di potere, re e regine in grado di utilizzare meglio di chiunque altro – meglio soprattutto di Frodo – il potere dell’Anello. Essi sanno che, rinunciando all’Anello, perderanno anche il potere che hanno (eccetto Aragorn, che re non è ancora e lo diventerà solo aver attraversato gli inferi). E tuttavia essi preferiscono non avere potere.
Il problema è dunque IL POTERE. A una prima lettura, è lampante che il potere non appare nel SdA come “qualcosa che si prende”, ma piuttosto come “qualcosa che ti prende”. Esso incatena (vedi gli spettri, vedi lo stesso Frodo). Il potere ti cambia, ha la proprietà di trasformare il Bene in Male. Questa è una spiegazione efficace e abbastanza semplice. Ma c’è dell’altro. La rinuncia al potere può apparire anche come ignavia, irresponsabilità, indifferenza; ma non è a Moravia che dobbiamo guardare, per decodificare il rapporto tra l’umanità e il potere come emerge dall’immaginario tolkieniano, piuttosto a Heidegger e alla sua “filosofia della Cura”.
I grandi personaggi del romanzo, raffigurazioni archetipiche di ciò che è autorevole e saggio – Aragorn, Galadriel, Gandalf – rinunciano al potere supremo, l’aver potere, perché sono l’essenza di un potere più alto, quello di chi ha cura (pensiamo all’Erich Fromm di Avere e essere). Il concetto di cura riveste in Essere e tempo l’importanza di un esistenziale, vale a dire di quello che in altri tempi corrispondeva a una categoria fondamentale dell’essere. L’aver cura è il modo in cui si manifesta l’esistenza dell’essere umano (l’esserci) nel mondo; anche quando questa cura non viene esercitata, ciò che spicca è la sua mancanza, l’inautenticità alienata di chi non è con gli altri, di chi non si cura. Nel mondo di Tolkien, dunque, i “grandi” rinunciano al potere perché hanno cura, perché sono al servizio del bene comune: degli altri, Aragorn, della natura, Galadriel, della giustizia, Gandalf.
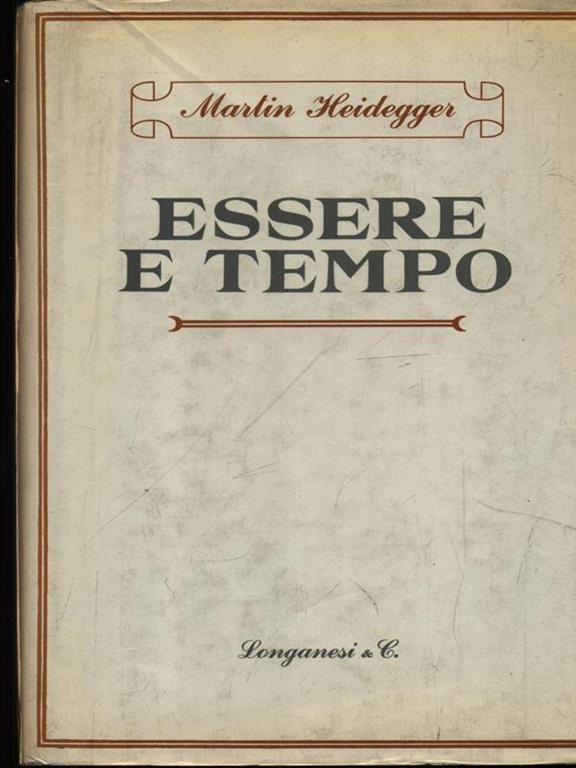
La prima traduzione in lingua italiana del capolavoro di Martin Heidegger
Se tutto ciò che ho scritto vale qualcosa, la conclusione è che l’opera di Tolkien va ben al di là della riduzione che ne è stata fatta a mero esercizio affabulativo, a capolavoro di un genere “fantasy” buono per quei dodicenni senza radici a cui l’industria culturale ci ha ridotti. A parte ogni considerazione sul fatto che il mondo degli elfi e dei maghi, e degli anelli del potere, è l’esito di un universo mitologico antichissimo che non ha nulla di estemporaneo (la mitologia nordica e le lingue ricreate a partire dagli studi delle grammatiche ugro-finniche costituiscono la tessitura profonda su cui è steso tutto l’impianto narrativo dello scrittore inglese, considerato uno dei maggiori esperti di letteratura anglosassone), ciò che alla fine conta di questa poderosa saga è, in chi legge al di là dei pregiudizi, la sensazione di un ritorno del narrativo alla sua responsabilità più autentica: radicare l’immaginario alle sue radici più profonde, farne una via che dal presente riporta al passato e nel passato riscopre le radici di senso dell’esistenza. Tolkien recupera una dimensione dell’immaginario che non ha nulla a che fare con il soggettivismo autoreferenziale dell’arte contemporanea, un’arte che ha rinunciato al simbolico, alla forza unificante degli archetipi, privilegiando lo stereotipo e l’istante senza memoria.
Post scriptum
Sull’assenza del simbolico nella cultura contemporanea ho scritto qui.

