[bel·léz·za]
OLTREPASSA CON NOI
YouTube
Ma io preferisco affidarmi alla tradizione nella quale mi sono formato, lunga settanta e più generazioni, ai maestri che attingendo a quella stessa tradizione mi hanno insegnato a guardare lontano. E, in questa tradizione, apprendo che il bello e il bene e il vero separati non esistono, perché non sono che valori riferiti alla medesima unità di senso, pesata da punti di vista convergenti. Un’unità oggi frantumata, attraversata come da uno scisma che ha diviso e reso i tre valori indipendenti l’uno dall’altro. Ma, in ordine a questa unità, non si può dare bellezza senza bontà e verità, così che: se cosa è buono non è anche bello e vero, allora è già meno buono; se cosa è vero non è anche bello e buono, allora non è poi così vero; e se cosa è bello non è anche vero e buono, forse non è davvero bello. In altre parole: dove sono menzogna e abbrutimento non c’è spazio per la bellezza, né per il bene è lecito mentire o ingrigire la vita. I tre valori, che insieme formano un trittico ontologico, considerati senza integrità e coincidenza, separati, mutano e in una certa misura si pervertono e cambiano segno.
In carenza di bontà e bellezza la verità è solo una verità logica, giuridica, formale, buona per il tribunale o per una procedura dimostrativa, è la verità dell’infanzia dell’umanità che ha bisogno del bilancino e non sostiene la contraddizione né l’indicibile. Mentre la bontà indifferente al suo resto ontologico, la bontà imposta con qualunque mezzo e a qualunque costo, porta verso l’inquisizione e il gulag. E la bellezza, isolata, ci smarrisce nel culto dell’apparenza, dell’effimero, dei corpi convertiti in plastica, del piacere individuale indifferente ai costi imposti agli altri, che giustifica il mercato dei corpi e i comportamenti di generazioni predaci, senza futuro, abilitate a pretendere cosa desiderano e a bruciare le rendite del futuro.
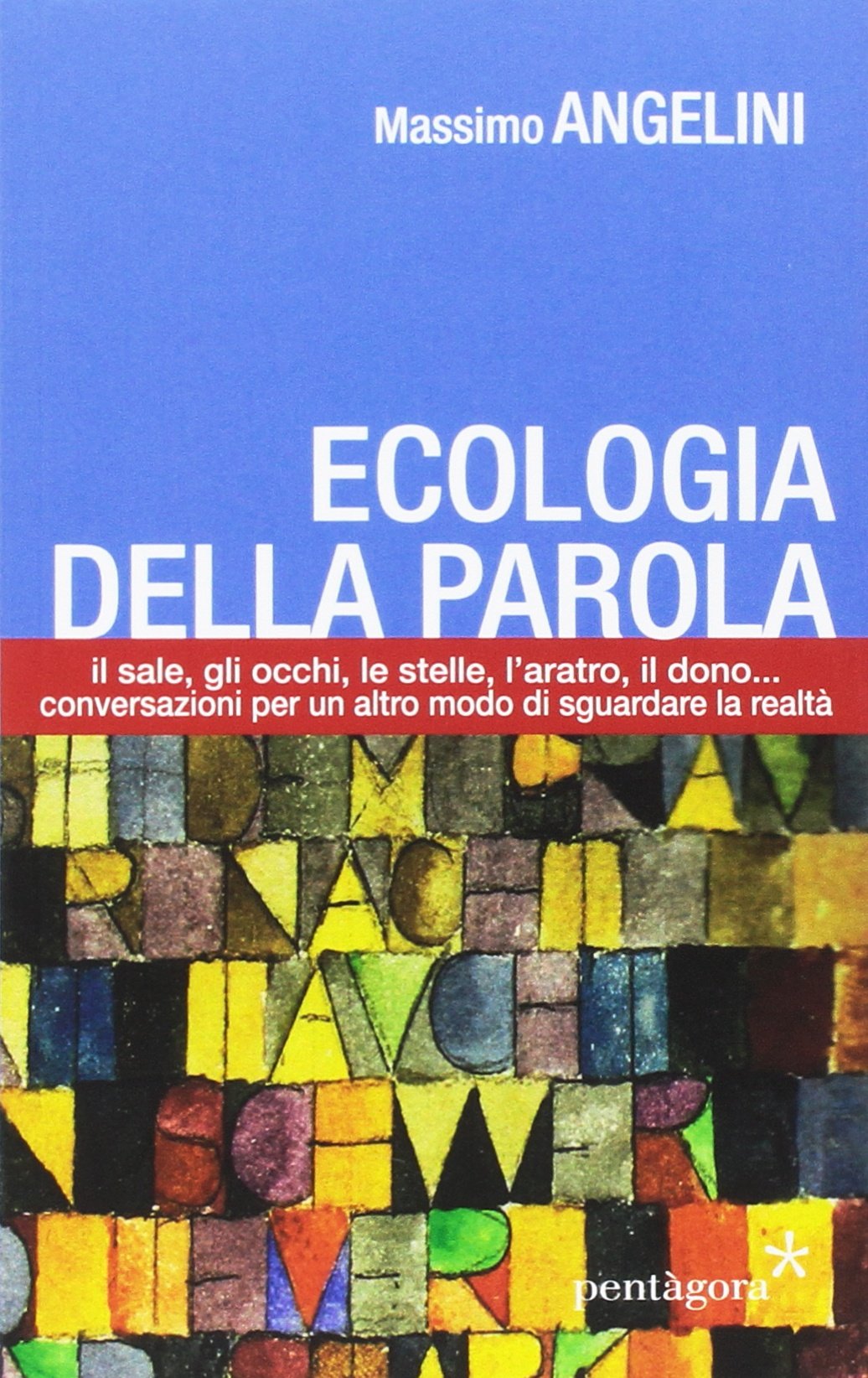
Bontà e bellezza sono intelligibili attraverso la verità, bellezza e verità sensibili attraverso la bontà, verità e bontà visibili attraverso la bellezza: e attraverso la bellezza la bontà è davvero visibile, come si racconta in Genesi, nel primo racconto della creazione, quando, al termine di ciascuno dei primi sei giorni, ogni cosa creata apparve buona.
In negativo, si può suggerire che non si dà bellezza dove manchino la verità e il bene comune. In positivo, che la bellezza, quella del trittico ontologico, è il riflesso della luce, di quella luce che non conosce il tramonto proclamata da Giovanni il teologo nella sua prima lettera: la bellezza è il divino che si rende accessibile ai sensi.
Dietro la filigrana di questa parola, una persona, un luogo, un oggetto sono belli, non tanto per ragioni di armonia, proporzione e perfezione delle forme – ideale classico e, a partire dal Rinascimento, squisitamente moderno – quanto per la luce che esprimono, anche attraverso i colori nei quali la luce si scompone. La bellezza, scintilla della luce che riflette ed esprime, quella che vive dietro l’apparenza delle forme, passa dagli occhi, strada per la luce che riceviamo e per quella che esprimiamo, quella che vive nell’intimo di ogni persona. Chissà, forse il sorriso è complice della bellezza proprio perché, inducendo un leggero allargamento della pupilla, permette di fare entrare e uscire più luce.
Se la pelle liscia, il volto giovane senza pieghe, senza scabrosità, chiaro, nsieme con tutto ciò che esibisce il dono dell’età comunica bellezza, è perché riflette la luce esterna, come la pelle invecchiata non sa più fare; d’altra parte è soprattutto alla vecchiaia che appartiene il poter esprimere una luce interiore meno schermata, incrostata, più pulita, più libera: certo, non si comunica bellezza per il solo fatto di esser vecchi né chi è vecchio comunica di per sé bellezza, ma se una possibilità di esprimere la bellezza profonda esiste, questa più facilmente appartiene a chi nel tempo ha potuto bruciare le scorie del cuore, come nella chiesa orientale si riconosce ai monaci e agli eremiti in stima di rispetto, se non di santità, ai quali ci si rivolge chiamandoli bel vecchio (kalós-ghéros = calogero).
La bellezza è il riflesso della luce, lo racconta il corpo senza vita di chi abbiamo conosciuto e ora come un fantoccio giace su un lettino. Col venire meno della luce, spenti, i cadaveri sono brutti, non attirano, allontanano, possono disgustare, fare paura, apparire estranei; eppure sono i corpi delle stesse persone che amavamo carezzare, che esprimevano bellezza. Ma ora, senza più calore, la pelle morta è livida, racconta l’ombra, non più la luce. Si dice che solo i corpi santi restino belli, come se ancora potessero esprimere una forte luce interiore; ma di solito non è così, lo sappiamo: sul letto di morte, spenti gli occhi, fredda la pelle, venuta meno la luce, non c’è più posto per la bellezza.
La bellezza è il riflesso della luce e per gli iconografi l’oro è luce; forse è per questa memoria remota nell’umanità, per questo modello che vive nel profondo del comune linguaggio nel quale ci siamo formati, che inconsapevolmente ci adorniamo di oro, cioè di luce, cioè di bellezza. Così le femmine volentieri indossano fili o riflessi o tinte di oro (o che vorrebbero richiamare l’oro) tra i capelli, come lampi per richiamare la bellezza; così s’indossano monili che riflettono la luce, e non tanto per il loro valore economico – ché altrimenti si indosserebbero banconote o assegni! – quanto, possiamo pensare, per l’inconsapevole richiamo antico alla luce e alla bellezza.

La bellezza è il riflesso della luce e la luce rende evidente e sensibile la bellezza, la luce del sole, la luce del giorno, ma anche quella delle stelle. La luce artificiale è affine solo alla bellezza artificiale.
La bellezza è il riflesso della luce, e se la luce, passando attraverso la pioggia o il prisma dei cristalli, racconta l’arcobaleno dei colori, allora la bellezza si esprime attraverso i colori e la loro varietà. Il bianco respinge la luce, il nero la inghiotte, il grigio – semi-nero – è un non-colore, ma l’oro la manifesta e la varietà dei colori la racconta. Così la bellezza si dispiega nella varietà e nei colori. E ancora le femmine, che più dei maschi alla bellezza sono prossime e devote e in un certo senso ne sono prigioniere, amano dotarsi di colori sul viso e nell’abbigliamento – così come, giocando col nero, per contrasto allargano la luce degli occhi – per indossare e comunicare bellezza, ulteriore riflesso di una sapienza trasmessa nella trama di un linguaggio antico e condiviso.
Come la bellezza, nell’unità del trittico ontologico anche il bene si accosta alla luce, e l’accostamento è intuitivo e noto, perché si sa e si dice che le cose buone si fanno alla luce del sole, mentre i delitti sono associati all’ombra e l’idea metafisica del maligno, signore della menzogna, alle tenebre; e come il bene si fa alla luce del sole e altrettanto apertamente si proclama la verità, mentre la parola infida si sussurra, si sibila, si dice di nascosto, in forma ambigua, lontana dai testimoni.
Così da una parte la luce e in particolare i colori e la varietà, dall’altra l’assenza di luce e il grigio e l’uniformità, ci offrono una chiave per riconoscere cosa è bello e cosa non lo è.
Perché fatichiamo a considerare belli una colata di cemento, un agglomerato di palazzi costruiti con materiali prefabbricati, una scala coperta di gomma a bolli, una striscia di asfalto su un prato, il cielo tappezzato dallo smog, i campi uniformi di un solo colore, le vigne allineate fino all’orizzonte come cimiteri di guerra? Perché hanno a che fare con l’uniformità, negazione della varietà, o col grigio, negazione dei colori, e attraverso la predominanza dell’uniformità e del grigio mostrano la distanza dalla luce.
🍒🍒DISORIENTATI E IN FUGA NEL METAVERSO
L’uniformità ha a che fare con la bruttezza, con la negazione di cosa è vivo (in fondo la stessa cosa), con la sterilità, con qualcosa di estraneo all’umano o che lo nega. È legata alla standardizzazione, alla proliferazione di misure estranee all’esperienza ed esterne alla misura umana, ai prefabbricati in cemento, al modulo pressoché unico che informa i blocchi industriali e i centri commerciali e le case e le chiese come declinazioni di un unico spazio di consumo, alle strade a misura di automobile vietate a chi cammina, ai commerci a misura di container, alla modulistica, ai quiz ministeriali, ai disciplinari: e molto di tutto questo, direttamente o indirettamente, ci parla del primato dell’economia sulla vita. Vive nei protocolli terapeutici, in una medicina tesa a contrastare la malattia indipendentemente dalla persona che anche attraverso quella malattia si esprime, in una scuola che applica programmi uguali e uguali metodiche di valutazione come se le persone fossero uguali (confondere la parità nei diritti, nella dignità, nel rispetto dovuto e nelle opportunità fornite, con l’uguaglianza tout court ha portato e porta conseguenze devastanti), nel prêt-à-porter di abiti e scarpe che se non calzano bene sarai poi tu ad adattartici, nei mobili ikea e nella standardizzazione dei gusti, in tutto ciò che porta a trattare le persone come individui, oggetti di statistiche, misurati, curati, trattati in relazione a comportamenti medi, a una media speranza di vita. Questo e altro ancora ha a che fare con la bruttezza.
Così è per l’agricoltura, declinata su poche specie e, su quelle espressioni che chiamare varietà fa male e grida all’inganno, perché sono uniformi anche in sé stesse, quasi insuscettibili di adattamento e mutazione come invece è storia per tutto quanto vive.
E qui il cerchio si chiude nella bruttezza che tende a coincidere col male possibile, con ciò che è inumano, con un paesaggio urbano del sottosopra dove il sopra – strade, case, oggetti – è rivestito di quello che nella normalità delle cose giace sotto – bitume, cemento, petrolio – e sotto avrebbe potuto continuare a stare. Quartieri che sono dormitori e terra di emarginazione, forme contemporanee del ghetto, seconde alle baraccopoli solo per il degrado igienico, non per quello morale ed estetico; luoghi segnati dalla dominanza del grigio, e chi ci vive vorrei sapere come lo possa altrimenti rispecchiare quel grigio se non con una vita tinta di grigiore esistenziale, con volti inespressivi nelle periferie o, anche ben dentro le città ma nelle periferie del cuore, con stomaci dilatati da scarti confezionati in veste di cibo, con il culto del denaro carente o la speranza nella fortuna, forma pagana della provvidenza. La bruttezza dilaga nelle città che marciano a denaro, tempo malpagato, eccitanti, coazione a ripetere di gioco d’azzardo o comportamenti predaci, pubblicità ovunque che domani, non passerà molto tempo, sarà tatuata sulla pelle, botteghe di tessuti miseri o strappati a malarte, utensili nati per non durare, e dilaga nelle periferie dove ti entra negli occhi e nel cuore e, oltre le periferie, sulla terra asfaltata da farmaci e stimolanti, solcata come miniera a cielo aperto.
Uniformità vs varietà, grigio vs colori, segmenti retti e spigoli vivi che la natura e, più in generale, la vita non conoscono, dunque rigidità vs movimento: quanto più ci si muove a scatti, tanto più si è prossimi agli automi; quanto più si parla a scatti, tanto più si è vicini alle macchine; quanto più si è rigidi, tanto più si è simili ai corpi spenti. La rigidità parla il linguaggio della bruttezza; rigidità nei movimenti, nelle parole, nelle idee; rigidità che non si avvicina, che non comprende, che non accoglie, che non include
Un criterio come un altro
Se la bellezza è tutt’uno con il bene e la verità ed è il riflesso della luce,
e se alla luce corrispondono la varietà, i colori, il calore, la vita,
e la vita si esprime nell’unicità, ma anche nel movimento, nel mutamento,
allora:
vedo un campo coltivato, e di questo campo pesando la varietà o all’opposto l’uniformità delle colture, l’accondiscendenza all’attitudine del terreno o all’opposto l’assetto geometrico indifferente alla sua forma, la molteplicità dei colori o la pervasività di un colore unico, allora posso dire se quello che vedo è bello o brutto, declinato alla fertilità o alla sterilità, e trarre un primo giudizio sul tipo di agricoltura che vi si esercita, se è buona, buona nel profondo, e se germina da un seme di verità oppure no;
poi vedo un luogo abitato, e di questo luogo pesando se gli edifici seguono un modulo unico o sono differenti, hanno un colore unico o esprimono molti colori, e se case e strade sono sotto il dominio incolore del grigio, e l’assetto delle strade è per linee diritte e angoli retti, e se dominano gli elementi di varietà e unicità o piuttosto quelli di uniformità e ripetitività, allora posso dire qualcosa della sua bellezza e anche trarre un giudizio sulla società e sulla ragione politica e sull’economia che hanno espresso un assetto abitativo comunitario o all’opposto un ghetto grigio: perché cosa produce la bruttezza non può essere buono né allineato alla verità;
poi ascolto un’idea, una teoria e pesandone la luce, dunque il colore e la varietà e il calore, delle parole e di chi le dice...
poi vedo una persona, e di questa persona pesando il modo di muoversi e parlare, la luce nello sguardo, l’uniforme indossata, la rigidità del pensiero, il grigio e il freddo oppure il colore e il calore delle parole e dei gesti...
Nell’uniformità, nel grigiore, nella rigidità di forme, parole e movimenti, nella ripetizione meccanica e seriale, nell’enormità di ciò che è oltre la misura umana, vedo l’indizio della bruttezza e, per metodo, soppeso che, dietro la bruttezza, si annidino ingiustizia e bugie
Autore


Zappo le parole per seminare idee.
Saggista, editore, fabbricante di lunari: ho curato ricerche e scritti dedicati alla storia delle mentalità, ai processi di formazione delle comunità locali fra antico regime ed età contemporanea, alla tradizione rurale, alla cultura della biodiversità, al sacro e alla dimensione dei simboli.
Coltivo la casa editrice Pentàgora: www.blog.pentagora.it
Sono autore di Ecologia della parola (Pentàgora 2020, II edizione)
Ho amato leggere Pavel A. Florenskij, Ivan Illich, James Hillman, Giuseppe Lisi, Christos Yannaras.

